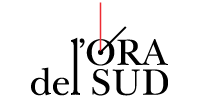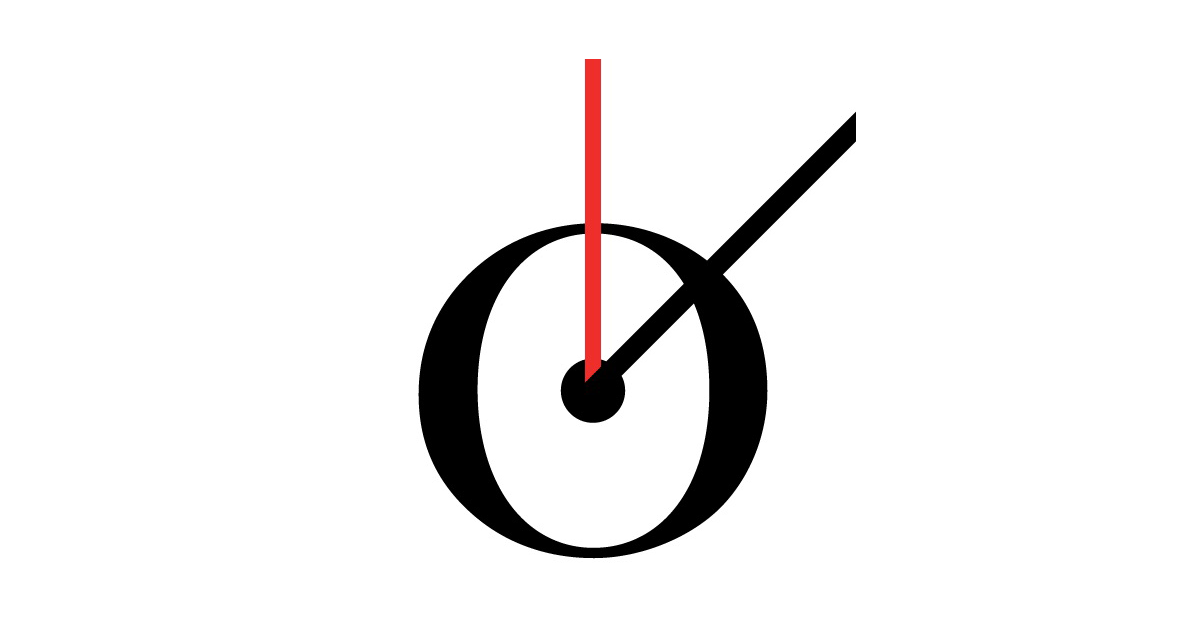“La verità è lo scatto migliore”. Robert Capa e l’invenzione del fotogiornalismo
FABIO FALABELLA
Robert Capa con una delle sue macchine fotografiche
La crisi delle parole e la potenza delle immagini nella vicenda umana e professionale di uno straordinario fotoreporter
Introduzione
La crisi delle parole e la potenza delle immagini
“Le immagini sono lì, basta catturarle”, cit. R. C.
È la vicenda umana di George Floyd, l’afroamericano ucciso da un agente di polizia di Minneapolis, a testimoniare tragicamente, oggi, l’importanza del fotogiornalismo, delle professioni di fotoreporter e videoreporter, nella società dell’immagine e dello spettacolo teorizzata da Guy Debord[1] ed in quella contemporanea della comunicazione digitale. I minuti interminabili e filmati, gli ultimi della sua vicenda umana, immortalati con un semplice telefonino di uso comune, uno smartphone, rimarranno una pietra miliare del giornalismo di strada, seppur involontario e non professionale, oltre che della lotta per l’emancipazione e la conquista dei diritti civili e della piena parità di razza negli Stati Uniti, a fronte delle decine di manifestazioni di protesta scatenate in tutto il mondo e delle emozioni universali che proprio quelle immagini hanno suscitato ai quattro angoli della terra, rilanciate secondo una dinamica di crescita esponenziale attraverso il web e i social network, come sempre più spesso accade per contenuti che finiscono per diventare virali. Ciò nonostante affermati sociologi della comunicazione, esperti del settore, giornalisti ed operatori dell’informazione lamentino di continuo, anche nelle pubblicazioni ufficiali di Ordini ed associazioni di categoria, la crisi crescente e continua della professione giornalistica e la marginalizzazione galoppante della funzione pur tanto necessaria ed imprescindibile, in Italia costituzionalmente garantita, dell’intermediazione. Senza ammiccare in alcun modo a qualsivoglia apologia dell’approssimazione, infatti, né lasciarsi tentare da un pericoloso e pernicioso scivolamento lungo il crinale sdrucciolevole della non professionalità e del non professionismo, va rilevato che questi due elementi appena accennati di sopra e solo apparentemente contrastanti sembrano essere in realtà entrambi epifenomeni di uno stesso, inesorabile processo globale di ipertrofia e super-diffusione della comunicazione a portata di mano o di click e della informazione da ciascuno e per tutti che caratterizza le società della post comunicazione di massa. E, anzi, secondo quanto affermato da autorevoli operatori dell’informazione, si potrebbe sostenere con altrettanta inevitabile evidenza che oggi siamo, o, meglio, possiamo e potremmo essere, tutti un po’ e in parte giornalisti e video operatori, se muniti dei nostri telefoni e dei nostri apparecchi digitali e senza rinunciare ad un minimo indispensabile di percentuale di ricerca della verità che la deontologia specifica insegna, raccomanda e pretende da chi si cimenti in tali attività. Va segnalata d’altro canto, sempre tenendo a mente i preziosi per quanto datati insegnamenti contenuti nella lezione di Debord[2], una costante marginalizzazione del testo scritto, di qualsiasi testo, in favore di una crescita inarrestabile della importanza delle immagini, fotografiche o video che siano; fenomeno anch’esso ampliato, potenziato e per certi versi esasperato da social network e piattaforme digitali, foriero altresì, causato e probabilmente corresponsabile di un pericoloso analfabetismo funzionale. Tralasciando in questa sede specifica ogni analisi più approfondita sulle considerazioni appena accennate di sopra, per ovvie ragioni di brevità necessaria ed alterità della traccia del lavoro di esame in oggetto, ciò che va custodito gelosamente ed opportunamente evidenziato, invece, è l’affermazione, presa in ipotesi e che proveremo a dimostrare, allora e sempre valida, scandita in un resoconto di viaggio, un’opera scritta a quattro mani con il premio Nobel per la letteratura John Steinbeck, “Diario Russo”, dal personaggio oggetto di questa tesi universitaria, considerato a tutti gli effetti ed a giusta ragione l’inventore del fotogiornalismo moderno, e del fotogiornalismo di guerra nello specifico: il fotografo ebreo ungherese ma naturalizzato statunitense Robert Capa. Il quale, in proposito a quanto appena scritto ed in merito ad una delle tappe raggiunte e condivise nel 1948 col suo compagno di avventure, la Stalingrado distrutta dell’epoca sovietica e post-bellica, affermava: “Con un paio di fotografie potrei far capire molto di più che non con migliaia di parole”.[3] Con ciò a sottolineare e cristallizzare la potenza narrativa delle immagini, di uno scatto ben fatto e messo a fuoco, di una fotografia che abbia in sé un anima ed una particolare, originale ispirazione, rispetto a qualsiasi e benché sostanziata ed approfondita argomentazione sintattica.
Capitolo 1
Cenni storici sulla professione di fotoreporter: nascita ed evoluzione del fotogiornalismo in Italia e all’estero
“La verità è l’immagine migliore, la miglior propaganda” cit. R. C.
La nascita della stampa illustrata fu quasi contemporanea all’invenzione della fotografia: già nel 1839 il fotografo francese Louis Daguerre realizzò le prime immagini su lastre di rame patinato d’argento, dodici anni dopo l’apparizione della prima fotografia, scattata dal suo collega, connazionale ed antesignano Niepce su lastre di stagno nel 1826 per ritrarre il paesaggio di Saint Loup de Varennes;[4] ma Daguerre fu il primo ad immortalare uno scorcio di Parigi, riducendo sensibilmente il tempo di posa e portandolo da più di 8 ore ad un più sostenibile margine di 8 minuti, ed il primo ad aver inserito un uomo all’interno di una fotografia, compiendo il grande passo per l’umanità ed i tecnici addetti ai lavori dalla panoramica al soggetto,[5] prefigurando la nascita e la successiva diffusione del primo piano, oggi evoluto nella dimensione universale del “selfie”, discendente digitale diretto dell’autoscatto di natura analogica. Presentando ai suoi lettori la strabiliante invenzione, così scriveva il 6 gennaio del 1839 la “Gazette de France”: “Le immagini fotografiche si dipingono da sole dentro la camera oscura e sono impronta durevole degli oggetti”,[6] a testimoniare il ricorso alla fotografia al fine di documentare degli avvenimenti sin dai suoi esordi. Nel 1842 nasce e viene pubblicato in Inghilterra il primo periodico contenente immagini, il settimanale intitolato “The illustrated London news”, il cui fondatore, Herbert Ingram, prometteva ai lettori “un resoconto continuo e dettagliato degli avvenimenti mondiali importanti, dei progressi sociali e della vita politica, per mezzo di immagini costose, varie e realistiche”. La rivista era venduta al prezzo di sei penny, era composta da sedici pagine e conteneva ben trentadue illustrazioni realizzate con tecniche xilografiche.[7] Al successo del magazine a colori britannico, seguì la fondazione di altre riviste illustrate con foto: “L’illustration” a Parigi, “L’illustrazione italiana” a Milano, la “Revista Universal” oltreoceano, a Città del Messico, “Illustriert Zeitung” a Lipsia, nella Germania orientale ed il “Frank Lesie’s illustrated newspaper” negli Stati Uniti, a New York. E pare opportuno menzionare il fatto che, nell’era delle cosiddette “fake news” che imperversano nella info-sfera fino a caratterizzare e condizionare le campagne elettorali degli Stati più potenti del mondo e gli avvenimenti di maggior rilievo della vita pubblica globale, tanto da far parlare alcuni scienziati di “infodemia”, quasi contemporaneo all’invenzione della fotografia fu l’immediato uso propagandistico e menzognero delle immagini fotografiche, di cui apparve subito chiara la potenza ritrattistica e descrittiva: nel 1855, infatti, fu affidato dal governo britannico a Roger Fenton, modesto pittore tra i fondatori della Royal Photografic Society, l’incarico di realizzare un reportage per immagini della guerra di Crimea, che venne da questi riportato come un conflitto apparentemente privo di morti e sofferenze, quasi che tutto apparisse in perfetto ordine, secondo i dettami dello stile imperiale di ispirazione vittoriana[8]. E ciò a dire che la fotografia, appena nata, già viene usata dall’autorità politica, le più alte gerarchie militari nel caso di specie, per alterare o modificare le informazioni destinate ai cittadini: proprio perché considerata sin da subito e universalmente veridica e veritiera, come un’arma a doppio taglio, la fotografia può essere usata per affermare il falso in modo convincente o addirittura incontrovertibile.[9] In altre parole, la fotografia, ma l’affermazione che segue vale e si sostanzia pienamente nel suo significato col fotogiornalismo raggiungendo sfumature estreme, non è mai stata, dunque, una autopresentazione o una rappresentazione della realtà, bensì, quasi sempre, un discorso soggettivo e spesso interessato o strumentale fatto da qualcuno, magari prezzolato o si direbbe oggi “embedded”, sulla realtà stessa.[10] Fu però alla fine dell’800, nell’epoca passata alla storia come quella del reporter, che nacque il fotogiornalismo vero e proprio come professione e definizione, in coincidenza con l’invenzione della lastra a mezzatinta. E, grazie alla box camera prodotta dalla Kodak, la fotografia approdò stabilmente sulle pagine, e sulle prime pagine, dei grandi e più prestigiosi quotidiani mondiali.[11] Agli albori del ventesimo secolo, precisamente nel 1902, una figura fondamentale nel panorama della fotografia mondiale, che grazie alle sue innumerevoli attività artistiche ed editoriali riuscirà a fungere da collante e ad unire filoni e tradizioni documentaristici europei ed americani, Alfred Stieglitz, diede vita al movimento della “Photo Secession”, realizzando una sorta di rivoluzione fotografica, dove l’uso della macchina da presa si contrapponeva a quello rigidamente controllato per ragioni politiche sovra descritto.[12] Tre anni più tardi, insieme con il fotografo Edward Steichen, fondò la “Galleria 291” in Fifth Avenue, a New York, iniziando le pubblicazioni della rivista “Camera Work”, quadrimestrale che raggiungerà 49 edizioni fino al giugno del 1917, nel bel mezzo del Primo Conflitto Mondiale, dando linfa vitale alla corrente della “Straight Photography”, fotografia diretta in Lingua Inglese, che avrebbe ispirato più tardi anche i lavori del nostro Robert Capa.[13] Un movimento nato, appunto, in diretta opposizione alla corrente del pittorialismo e ad ogni forma di manipolazione dell’immagine: “Qualunque cosa in grado di alterare la fotografia rende automaticamente meno puro lo scatto e, quindi, meno vero”, scriveva a mo’ di epigrafe testamentaria in una delle edizioni della rivista. La “Straight Photography” si sviluppò velocemente, soprattutto negli Stati Uniti, riscuotendo plauso e consenso tra gli addetti ai lavori più esperti, in concomitanza con la nascita della figura di fotoreporter e con la crescente attenzione del pubblico per la fotografia documentaria.[14] Fu così che, ribaltando presupposti, canoni tecnici ed esiti del lavoro di Fenton, con l’evolversi della società industriale, molti fotografi cominciarono a raccontare la realtà, o almeno a provare di farlo, anche se scomoda. A tal proposito, sono famose e divenute celebri le immagini di Lewis Hine, il quale con estrema crudezza e piglio giornalistico da cronista di strada documentò la vita misera degli immigrati in arrivo a Long Island ai primi del Novecento e le condizioni dei bambini costretti dalla povertà e dalla fame a lavorare nelle fabbriche sempre più grandi ed estranianti in nome del progresso e al prezzo di un tozzo di pane. Anche Paul Strand e Walker Evans sostennero con entusiasmo il movimento della fotografia diretta, cui si fregiarono e si sforzarono professionalmente ed intellettualmente di appartenere, raccontando per immagini, negli anni Trenta, la difficile realtà disagiata e degradante delle condizioni delle classi subalterne e dei “poor workers” sottoproletari che abitavano i quartieri più poveri e fatiscenti della Grande Mela in piena espansione capitalistica dopo la Grande Depressione.[15] Sempre a New York, non a caso, e parallelamente, nasce e si sviluppa la figura del fotogiornalista d’azione, che sarà sublimata e raggiungerà picchi di finezza e di immediatezza inarrivabili negli scatti di Capa due decenni dopo.[16] Di questi reporter d’assalto, scaduti o comunque trasformatisi nei paparazzi dei giorni nostri, apparsi in Via Veneto a Roma negli Anni Sessanta per fotografare “La dolce vita” descritta nella sua pellicola da Federico Fellini di registi di casa nostra e star internazionali del cinema e dello spettacolo, poi lanciati in scooter alla rincorsa folle dell’automobile che trasportava Lady Diana Spencer e Dodi Al-Fayed nella notte del 31 agosto 1997 lungo il tunnel del sottopasso al Ponte de l’Alma a Parigi, dove la principessa trovò la morte dopo uno schianto terribile, il primo che la storia e le cronache giornalistiche ricordino fu “Weegee”, pseudonimo di Arthur Fellig.[17] Nato professionalmente come stampatore negli anni Venti presso la “Acme Newspictures”, lasciò la sua prima attività per concentrarsi, e in un certo senso inventare, quella di free-lance, frequentando assiduamente il quartier generale della polizia a Manhattan, stringendo amicizia e rapporti non sempre cristallini con i poliziotti, tanto da entrare a tal punto in correlazione con loro da essere avvisato in ogni occasione per giungere per primo sulla scena di un crimine o sul luogo di un incidente o di una rissa notturna. E tanto da installare addirittura una radio della polizia sulla sua auto per essere sempre aggiornato sugli ultimi eventi criminali e i fatti di cronaca nera avvenuti in città.[18] La “Straight Photography” fu abbracciata in toto anche da Ansel Adams, che, innamorato della natura e dei grandi parchi americani, dedicò la maggior parte della sua vita professionale a fotografarne gli sprazzi di bellezza ancora vergine nella maniera più reale e veritiera possibile. Fu grazie a questo suo modo personale di concepire l’immagine, e all’amicizia che lo legava a Edward Weston, che nel 1932 nacque il gruppo “f/64”, nome dedicato all’apertura del diaframma nell’apparecchio fotografico, necessaria ed utile ad ottenere il più alto valore di profondità di campo con i mezzi allora a disposizione dei fotoreporter. Sua fu anche l’invenzione del sistema zonale, uno strumento che, congiuntamente all’iperfocale, aiuta molto il fotografo ad avvicinarsi ad una rappresentazione genuina della realtà che si manifesta ai suoi occhi. D’obbligo, in coda ma non a margine di quest’elenco, la citazione di un’altra amica e collega di Adams, Dorothea Lange, giovane reporter freelance che si trasferì da New York a San Francisco e che dal 1935 al 1939, assieme ad altri grandi fotografi, fu alle dipendenze della FSA (Farm Security Administration) per documentare la grande depressione americana: iconica, al riguardo, divenne la sua foto intitolata “Migrant Mother”.[19] Infine, negli Anni ’40, mentre in Europa si affermavano la corrente umanista francese di Robert Doisneau, Willi Ronis e Brassaï ed il neorealismo post-bellico italiano di Gianni Berengo Gardin, Mario Giacomelli e Ugo Mulas, negli Stati Uniti nacque la famosa “Magnum Photos” di Rober Capa, Henri Cartier Bresson, David Saymour e George Rodger.[20] In Italia fu la necessità di riprodurre esattamente e facilmente i tanti monumenti storici e architettonici presenti sul territorio a dare immediatamente grande impulso all’utilizzo ed allo sviluppo della tecnica fotografica, che, appunto, alimentò in modo particolare il settore della riproduzione artistica a scopo archivistico e di compendio, mentre bisognerà aspettare il 1885 per l’apparizione della prima fotografia ufficiale riprodotta sulla “Illustrazione Italiana”.[21] Saranno poi le due Guerre Mondiali a sancire la diffusione della pratica fotografica tra i professionisti, della fotografia tra il pubblico del Belpaese e della abitudine tanto cara a Capa, e per cui divenne famoso, della fotografia istantanea, non più in posa, come venivano immortalati i capi e le tribù di Indiani d’America nelle riserve, con la crescita graduale e complementare di una cultura visiva diffusa in grado di superare quella scritta a livello comunicativo.[22] Il vero banco di prova alle nostre latitudini, non circoscritte alla madrepatria ma estese alla geografia di conquista imperialista, fu per l’industria bellica l’invasione della Libia, preludio di quanto sarebbe accaduto di lì a poco con lo scoppio della Grande Guerra. Durante il triennio 15-18, tristemente famoso nei nostri manuali di storia, fu definitivamente spazzato via dal panorama italiano quello che la “Straight Photography” definiva sprezzantemente il ciarpame pittorialista: negli archivi di Stato, e in numerose raccolte private, è conservato ancora oggi un numero enorme di immagini e scatti di questo conflitto, esecrato da molti ma esaltato dai nazionalisti, grazie all’opera svolta durante il pieno svolgimento delle operazioni belliche dal Reparto Fotografico del Comando Supremo del Regio Esercito.[23] La censura militare, tuttavia, come era già avvenuto altrove in passato e come sarebbe accaduto dovunque in seguito, trasformò la fotografia in uno strumento di propaganda, attraverso la scelta strumentale di immagini iconiche che ritraevano una parte della guerra, quella più conveniente e confacente alle volontà della classe dirigente ed alle necessità delle alte gerarchie militari: da questo punto di vista, divennero celebri e popolarissime quelle pubblicate dalla “Domenica del Corriere” e dalla “Tribuna Illustrata”, testate che si fecero promotrici di una narrazione obliqua e a senso unico anche attraverso i propri numerosi corrispondenti, che fornivano il materiale fotografico di prima mano.[24] Dopo la guerra la fotografia italiana partecipa ai grandi movimenti internazionali di avanguardismo artistico e, con l’ascesa dei periodici illustrati, diviene un potere non più effimero e sempre più cogente con cui fare i conti,[25] fino alla apologia propagandistica concepita durante il ventennio del regime fascista e realizzata ad opera dell’Istituto Luce. In questo periodo, la qualità delle immagini realizzate, così come la limitata ambizione e la scarsa lungimiranza del progetto complessivo, fanno segnare un distacco con ciò che avviene contemporaneamente nell’America della Farm Security Administration e danno la misura del ritardo che va accumulando la cultura fotografica italiana, foriero di una mancata evoluzione dovuta in special modo alla concezione letteraria dell’informazione e della informazione fotografica, che finisce per svilire il ruolo svolto dalla cronaca e dalla fotografia stessa, ciò vale ancor di più per qualsiasi forma di reportage, e dare luogo ad una sorta di provincialismo culturale che ha pesato sugli sviluppi del fotogiornalismo italiano fino ai giorni nostri.[26] E infatti, mentre dagli anni Venti agli anni Cinquanta del secolo scorso, fino al momento del suo lento regresso a fronte della comparsa della televisione, il fotogiornalismo internazionale conobbe uno straordinario sviluppo dovuto a nuove idee, nuove tecniche e finanche alla apparizione dell’apparecchio di piccolo formato, compatto, rapido e maneggevole, la Leica, che diede forte impulso al reportage rivoluzionando completamente l’impaginazione delle riviste specializzate grazie al suo caricatore da 36 pose,[27] in Italia si assiste, a causa delle limitazioni imposte dal regime, intento a censurare i pericoli connessi alla verità potenzialmente espressa dal mezzo fotografico, ad un arresto, una rottura dell’evoluzione del fotogiornalismo.[28] Con l’unica eccezione della Publifoto di Vincenzo Carrese, fondata negli anni Trenta, una delle agenzie più significative della storia della fotografia italiana: il fotogiornalismo, così, un tempo vigoroso anche nella Germania pre-nazista, continuerà ad esistere in senso stretto soltanto in Canada e Negli Stati Uniti, con la fotografia asservita nell’Italia mussoliniana alla costruzione del mito fascista e alle immagini iconografiche del Duce.[29] Questa, però, è un’altra storia, di cui, nel nostro racconto, funge da trait d’union proprio la figura di Robert Capa, al seguito delle truppe alleate nella risalita dello Stivale per la liberazione del nostro popolo dal giogo nazi-fascista.[30]
Capitolo 2
“Leggermente fuori fuoco”: la vicenda biografica e professionale di Robert Capa dalla Magnum Photos al Vietnam
“Come fotografo di guerra spero di rimanere disoccupato tutta la vita” cit. R. C.
Fotografo di pancia e di concetto, uomo curioso prima ancora che artista capace, Robert Capa fu al seguito delle truppe alleate sbarcate in Sicilia il 10 Luglio del 1943,[1] in quello che, appunto, il primo ministro inglese Winston Churchill definiva il “ventre molle” dell’Asse, che diedero luogo, congiuntamente all’azione dei partigiani, alla liberazione dell’Italia. Pseudonimo di Endre Ernő Friedman, Capa era nato a Budapest il 22 ottobre del 1913 per emigrare negli Stati Uniti in seguito alla diffusione dei pogrom contro gli ebrei che caratterizzarono in Europa il periodo tra le due guerre mondiali.[2] Studiò Scienze all’Università di Berlino, fra il 1931 e il 1933, poi dovette lasciare la Germania nazista a causa delle sue origini ebraiche con l’accentuarsi e il diffondersi delle persecuzioni antisemite ad opera delle SS di Hitler.[3] Reporter di guerra per eccellenza e per definizione, grazie ai meriti e ai gradi conquistati sul campo e sul terreno di battaglia, morì il 25 maggio del 1954 a Tay Ninh, in Vietnam, vittima probabilmente del fuoco amico, saltando su una mina mentre era imbarcato e tallonava da vicino i soldati americani impegnati nella guerra contro l’esercito di “musi gialli” del comandante Giap e del leader supremo Ho Chi Min.[4] Finì così la sua esperienza terrena, con un epilogo cinematografico e la sceneggiatura degna di un film o di un romanzo, in modo spettacolare e da vero professionista, con l’apparecchio fotografico al collo, come si conviene a tutti quegli eroi umani che sono capaci di seguire fino in fondo il loro istinto e addirittura di immolarsi per la propria passione.[5] Molti anni dopo, in occasione della pubblicazione celebrativa di alcune sue foto, sensazionali e bellissime, il suo amico e compagno di viaggio in Russia John Steinbeck avrebbe dichiarato: “Capa sapeva che cosa cercare e cosa farne dopo averlo trovato. Sapeva, ad esempio, che non si può ritrarre la guerra, perché è soprattutto un’emozione. Ma lui è riuscito a fotografare quell’emozione conoscendola da vicino”.[6] I suoi reportage rendono testimonianza giornalistica di cinque diversi, grandi conflitti bellici: la guerra civile spagnola (1936-1939), la seconda guerra sino-giapponese (che seguì da inviato nel 1938), la Seconda Guerra Mondiale (1939-1945), la guerra arabo-israeliana del 1948 e la prima guerra d’Indocina (1954) durante la quale trovò, come già detto di sopra, la morte.[7] E, in effetti, come fotoreporter Capa divenne famoso, guadagnandosi l’epiteto che ancora oggi conserva postumo di primo fotografo di guerra, grazie alla foto intitolata “Il miliziano colpito a morte”, scattata esattamente nel corso della guerra civile spagnola e della resistenza repubblicana contro i golpisti del generalissimo Francisco Franco, di cui, per amor del vero, alcuni discutono tuttora mettendone in dubbio l’autenticità.[8] Secondo i critici più accreditati, però, non v’è dubbio che fosse opera di Capa quell’immagine, in cui, ed è questo un suo merito squisitamente tecnico, tanto più di valore alla luce dei mezzi a disposizione allora, che non consentivano certo la maneggevolezza e l’immediatezza di esecuzione dei moderni apparati digitali, in cui, dicevamo, il nostro protagonista riuscì ad immortalare un combattente nell’attimo esiziale in cui spirava colpito a morte dal nemico. Che fosse sua, in realtà, non è mai stato insinuato il contrario, ma ci fu chi sostenne che le circostanze dello scatto, che divenne un’icona del secolo scorso e lo è anche oggi, rimanendo una pietra miliare nella storia mondiale della fotografia, non sarebbero veritiere e che Capa lo avrebbe preparato, predisponendo la scena con un artefatto. Fu lui stesso, però, in un’intervista radiofonica concessa ad un’emittente statunitense nel 1947 a raccontare la sua verità su come andarono effettivamente le cose: “Ho scattato la foto in Andalusia, mentre ero in trincea con venti soldati repubblicani che avevano in mano vecchi fucili e morivano ogni minuto. Ho messo la macchina fotografica sopra la mia testa e, senza guardare, ho fotografato il soldato mentre si spostava sopra la trincea: questo è tutto”,[9] affermò, con l’apparente candore e la naturalezza di chi non mente ed è orgoglioso del suo lavoro, consapevole che la bellezza e l’autenticità, il valore di una foto dipendano esclusivamente e siano possibili soltanto con la genuina naturalezza di chi scatta provando a cogliere l’essenza delle cose, dei fatti e degli avvenimenti. Del resto, lo stesso Capa amava affermare che, “se le tue foto non sono buone, vuol dire che non eri abbastanza vicino”.[10] La sua fu una vita spericolata, paragonabile alle esperienze esistenziali diverse, ma simili e comparabili, dei protagonisti della Beat Generation, degli attori del cinema alla Jack Nicholson di Easy Rider e dei romanzieri alla Kerouac, “on the road”, costantemente sulle strada a sporcarsi le mani e consumare le suole delle scarpe come si voleva e si vorrebbe per un buon cronista. Una vita in cui non mancarono la sofferenza, in certi periodi la miseria, e il caos che amava raccontare con le sue fotografie, fatta di donne, grandi bevute e attrazione fatale per il pericolo.[11] Oltre che come prototipo, mai termine fu più azzeccato, del fotografo di guerra, Capa è passato alla storia anche come il fondatore dell’agenzia fotografica Magnum, che con i suoi canoni etici ed estetici definisce ancora oggi le caratteristiche principali del fotogiornalismo e del modo precipuo di quest’arte di raccontare il mondo. Tra le più importanti agenzie fotografiche, la Magnum Photos ha la forma di una società cooperativa e riunisce sessanta tra i migliori fotografi del mondo, pure con lo scopo di proteggere il diritto d’autore in ambito fotografico e garantire la trasparenza dell’informazione.[12] L’etica professionale della Magnum, infatti, prevede che le immagini scattate rimangano di proprietà del fotografo e non delle riviste che le pubblicano, consentendo così all’autore di scegliere soggetti e temi delle stesse ed orientarne l’ideazione e la produzione verso uno stile aderente il più possibile a quello del singolo professionista, in ciò libero da vincoli, come voleva, predicava e praticava Capa con la sua arte. L’idea della sua fondazione venne a Capa e nacque nei cenacoli che questi amava tenere intrattenendosi con i suoi sodali d’amicizia e lavoro presso il MOMA (Museum of Modern Art) di New York: il nome fu scelto perché i convenuti gradivano accompagnare le loro dissertazioni, le loro sperimentazioni teoriche e le loro discussioni con una bottiglia del famoso vino francese così chiamato. I membri della cooperativa si impegnarono sin dagli esordi a pretendere dagli editori il controllo totale della messa in pagina delle immagini prodotte e la verifica delle didascalie che le accompagnavano e le spiegavano ai lettori.[13] Decisero, inoltre, di detenere la proprietà dei negativi delle stesse, fatto assolutamente nuovo per l’epoca: ogni fotografo poteva decidere dove, come e per chi lavorare.[14] La libertà d’azione significava poter realizzare reportage più personali, veritieri e di ampio respiro, anche socio-culturale, senza strettoie, paletti o interferenze politiche, commerciali, imprenditoriali o editoriali di sorta, in cui l’autore potesse raccontare la verità, o una sua parte, meglio, di più e più in profondità. Per queste ragioni, i servizi della Magnum Photos si imposero sin da subito per la capacità fresca e inusitata di essere nel mondo e al centro della notizia,[15] di stare sul pezzo, si direbbe con accezione e linguaggio tipicamente giornalistici. Nella consapevolezza e nella verificata certezza che nessun fotografo è uguale ad un altro e che la forza narrativa di ogni singolo scatto insiste e dipende dalla creatività di ognuno e dalle imprese individuali, di vita e professionali, in cui ciascuno si cimenta.[16] E i risultati furono esperimenti, a quel tempo del tutto nuovi e per certi aspetti inimmaginabili prima, di un modo di comunicare, produrre e vivere la fotografia senza alcun limite e senza confini.[17] Tra i capolavori realizzati nel suo lavoro da Robert Capa, va menzionato assolutamente il libro intitolato “Leggermente fuori fuoco”, traduzione italiana dall’originale Inglese “Slightly out of focus”: un testo coinvolgente e appassionante, ad un tempo autobiografia e testamento del fotografo ungherese, in cui Capa racconta il suo percorso umano e professionale tra aneddoti, incontri, amicizie con personaggi illustri e infinite, forse ineguagliabili avventure vissute da solo o in compagnia durante i suoi viaggi.[18] Un saggio arricchito naturalmente da immagini uniche che hanno fatto la storia della fotografia e che Capa scelse e archiviò personalmente tra le decine di migliaia dei suoi scatti migliori, era molto pignolo e perfezionista sino alla patologia secondo Steinbeck,[19] raccontate una per una con una prosa abile ed ironica con le parole che, nel suo caso e con una prospettiva ribaltata rispetto alla consuetudine, fanno da corredo e da compendio alle fotografie.[20] Un’opera che è insieme un libro di fotografia di gradissimo pregio e un particolarissimo manuale di storia: un inno alla professione del fotoreporter di guerra, un diario completo delle memorie di guerra del fotografo ungherese, corredato ovviamente di foto uniche. Un testo che divenne subito leggendario,[21] col titolo mutuato dalle didascalie che sul magazine Life accompagnavano le sue foto dello sbarco in Normandia compiuto dagli alleati a partire dal 6 giugno 1944[22] in una delle più grandi operazioni militari congiunte che la storia ricordi, rovinate in fase di sviluppo da un tecnico di laboratorio[23] ma forse, per questa ragione, ancora più affascinanti e suggestive, al netto dell’irritazione mai sopita di Capa per l’accadimento.[24] Il racconto, preceduto da una nota del fratello, Cornell Capa, e dall’introduzione di Richard Whelan, mantiene la freschezza dello sguardo del fotoreporter, la sua fervida ed instancabile, incontentabile e inappagabile passione, la sua acuta e gradevole ironia colta, lo spirito di avventura di un grande, ineguagliabile testimone del secolo scorso e del nostro tempo.[25] E alterna le vicende del fotoreporter con una storia d’amore travagliata, suggellata dal dolore dei suoi più cari affetti per la morte avvenuta pochi anni dopo in Indocina. A corredo e compendio del testo, in copertina, è lo stesso Capa a scrivere: “Un fotoreporter di guerra beve sicuramente di più, ha più ragazze, è pagato meglio ed è più libero rispetto a un soldato”, cristallizzando col suo pensiero la sua idea di professione. Poi, provando a spiegare ciò che lo aveva indotto a sceglierla, continua: “Ma a un certo punto del gioco, avere la libertà di decidere dove stare e quindi anche la possibilità di comportarsi da vigliacco, senza essere giustiziato per questo, è una tortura. La posta in gioco del corrispondente di guerra – la vita – è nelle sue mani, può puntarla su questo o quel cavallo, oppure rimettersela in tasca all’ultimo minuto”. E, ancora, per nulla inibito dalla contraddizione sottolineata e di cui era consapevole, né intimorito dal compito arduo e pericoloso che la sua scelta avrebbe comportato, chiosa: “Sono un giocatore. Così decisi di unirmi alla Compagnia E nella prima ondata”.[26] Nella prefazione al testo, è illuminante della personalità e dell’ardore professionale di Capa, nonché della stretta correlazione che, per tutta la vita, legò il suo lavoro alla guerra, quanto scrisse di lui nel 1999 in occasione di una commemorazione e della ripubblicazione del libro, il fratello Cornell: “Mio fratello Robert Capa assunse volontariamente l’incarico di raccontare l’inferno che gli uomini si sono fabbricati da soli: la guerra. La sua capacità di sentirsi vicino a quanti soffrivano in guerra e le sue fotografie hanno trasformato in istanti di eternità non solo gli eventi cruciali ma anche le prove cui erano sottoposti i singoli. Le vicende travagliate di cui è stato testimone furono tragiche, ma quel che gli dava forza erano il senso dell’umorismo e la tendenza a minimizzare il suo stesso coraggio. Queste sono state le sue caratteristiche essenziali, tanto nella vita quanto nel lavoro.[27] Ma dietro l’umorismo, l’ironia e il coraggio si nascondeva una grande sensibilità, che una volta lo portò a dichiarare, con uno dei suoi tipici understatement (affermazione), che non è facile, sono parole sue queste, starsene sempre da una parte senza poter far nulla, tranne che registrare le sofferenze che vedi intorno a te.[28] La sua vita, la vita di Robert Capa, è la prova lampante delle difficoltà superate, delle sfide raccolte, di tutte le scommesse vinte tranne l’ultima, quando la mina su cui poggiò il piede in Indocina mise fine al suo lavoro di testimone.[29] Era nato privo di mezzi per viaggiare, con una lingua che non serviva a nulla oltre i confini di un piccolo paese come l’Ungheria, ma riuscì a conoscere – e raccontare aggiungiamo noi – il mondo attraverso un mezzo di comunicazione universale come la fotografia. In questo modo, ha potuto parlare a tutti noi, allora come oggi. Durante il suo breve passaggio sulla terra visse e amò molto. Nacque senza denaro e così morì. Quel che ci ha lasciato è la storia del suo viaggio irripetibile e una testimonianza visiva che proclama la fede nella capacità degli uomini di sopportare tante avversità e, a volte, di farcela”.[30] E altrettanto illuminante è ciò che racconta nell’introduzione il suo amico e producer Richard Whelan: “Il precoce adolescente di Budapest che un giorno sarebbe diventato famoso con il nome di Robert Capa non aspirava affatto a diventare fotografo, voleva scrivere reportage e romanzi. Per caso e non per scelta passò – o fu spinto dalle circostanze – alla fotografia. Neanche quando era all’apice della carriera di fotoreporter, grazie alle immagini di ineguagliabile valore scattate in guerra – in Spagna, in Cina e in tutto il teatro europeo del secondo conflitto mondiale – Capa abbandonò mai il sogno di essere prima di tutto uno scrittore e poi un fotografo.[31] Dal momento che ormai quasi tutte le copie dell’edizione originale di Slightly Out of Focus hanno perso la sopraccoperta, molti lettori si immergono nel testo di Capa del tutto ignari dell’avvertenza che un tempo compariva sulla bandella. In quelle righe Capa avvisava i lettori che, queste sono parole sue, vergate di suo pugno, visto che scrivere la verità è ovviamente tanto difficile, nell’interesse della verità stessa mi sono permesso ogni tanto di andare appena oltre, altre volte di fermarmi appena al di qua. Tutti gli avvenienti e le persone descritte in questo libro sono accidentali e hanno qualcosa a che fare con la verità.[32] Questa avvertenza era necessaria per un semplice motivo: Capa aveva scritto il suo libro non per farne un imperituro documento storico ma perché, con qualche cambiamento, diventasse la traccia di un’avvincente sceneggiatura. Molti degli aneddoti raccontati nel libro erano assolutamente veri, ma Capa aveva reso irriconoscibili i nomi di alcuni personaggi, aveva accelerato la sequenza temporale di certi avvenimenti e modificato qualche particolare secondario. Capa era un affabulatore nato e poche cose gli davano piacere come l’allietare amici o perfetti estranei con esilaranti resoconti delle sue avventure picaresche. Quando era importante raccontare la verità parola per parola, lo faceva. Ma quando nessuno insisteva per avere la pura verità, tranne un noioso pedante, Capa non vedeva per quale ragione dovesse astenersi dal ricamare un po’, magari per migliorare una storia già buona rendendola più divertente, il più delle volte a sue spese.[33] Ultimamente, la reputazione di Capa è stata riscattata dalla più grave delle accuse rivolte alla sua onestà a proposito di un episodio che per lui contava moltissimo. Un anziano giornalista britannico, la cui memoria non era più affidabile, ha sostenuto che Capa avesse scattato la famosa foto del miliziano spagnolo colpito durante un’esercitazione e non nel corso di una battaglia vera e propria. Ma Capa quel giorno si trovava lontano da dove sosteneva il giornalista, e uno storico spagnolo ha confermato che l’uomo nella foto – identificato sia da lui sia dai familiari come Federico Borrel García – fu colpito a morte esattamente nel momento e nel luogo in cui Capa affermava di aver scattato la foto, cioè nei pressi di Cerro Muriano, un villaggio qualche chilometro a nord di Córdoba, il 5 settembre 1936”.[34] E questo per amore di verità, quella che Capa, seppur talora arricchita per rendere il racconto più avvincente, amava tanto, sin tanto da sacrificarvisi. A suggello e sigillo di quanto siamo venuti fin qui affermando, e a testimonianza della inarrestabile curiosità intellettuale e della inesauribile sete di conoscenza e verità del fotografo di origini ungheresi, della sua spontanea ed imprescindibile necessità di sperimentare per andare oltre il consueto del visivo e del luogo comune, valga quanto scritto a mo’ di tributo nei confronti di Capa, con cui aveva stretto una calorosa amicizia in Sicilia nel 1943, dal giornalista statunitense e premio Pulitzer John Hersey, in un articolo intitolato “The man who invented himself” (L’uomo che inventò se stesso) che fu pubblicato sulla rivista “47” e di cui si dà menzione a margine della introduzione di Whelan.[35] Hersey scrisse: “Nonostante tutte le sue invenzioni e i suoi atteggiamenti, da qualche parte, nell’intimo, Capa ha una realtà. È il suo talento, un misto di umanità, coraggio, gusto; in esso si mescolano un atteggiamento romantico, il disprezzo per la mera tecnica, la naturale inclinazione verso ciò che è opportuno e la capacità di rilassarsi. In fondo a tutto, c’è persino un pizzico di modestia. Capa ha l’intuito del giocatore d’azzardo… Ha un gran senso dell’umorismo. Ha un’idea chiara di cosa fa di una foto una grande foto. La foto, dice, è un frammento di realtà, che mostra a chi non era presente la verità degli eventi molto più di quanto possa fare l’intera scena. Soprattutto – e balza agli occhi nelle sue fotografie – Capa, che pure ha speso tante energie per trovare soluzioni vantaggiose per sé, nutre un profondo senso di empatia umana per gli uomini e le donne rimasti intrappolati nella realtà”.[36]
Capitolo 3
Una vita in viaggio: il fotoreporter e i suoi libri da “Questa è la guerra! Robert Capa al lavoro” a “Diario Russo”
In una guerra si deve odiare qualcuno oppure amare qualcuno; è necessario avere una posizione oppure non si può capire ciò che succede” cit. R. C.
Sono pochi, dunque, i fotografi del secolo scorso ad aver avuto un’influenza così diffusa e duratura e una importanza così fondamentale e generalizzata come quella universalmente tributata a Robert Capa. Da quanto sinora scritto e testimoniato, si comprende bene come ciò sia dovuto non solo alla forte, singolare ed originale iconicità delle sue immagini, o alla sua capacità di affrontare il lavoro di fotogiornalista con una temerarietà senza pari e che culminò con la sua stessa morte, sul campo, in Vietnam nel 1954.[37] Piuttosto, attraverso il suo esempio e le sue fotografie, Capa consentì al pubblico del ventesimo secolo di vedere per la prima volta senza filtri le conseguenze della guerra moderna e meccanizzata, che fu del resto il suo principale oggetto di studio, sperimentazione e lavoro.[38] Negli anni dei brutali assalti dei carrarmati e dei devastanti bombardamenti aerei, Capa mise costantemente e insistentemente a fuoco, o leggermente fuori fuoco[39] per essere quanto più vicino possibile al soggetto dello scatto e raccontare così la sua verità e la realtà seppur frammentata, il rozzo ed umile soldato, buono per essere un nome nell’elenco del monumento ai caduti del milite ignoto, inquadrandolo nella sua solitudine esistenziale, al pari dei rifugiati in fuga sradicati dalle loro terre.[40] Immortalando le persone in immagini intense e cariche di empatia, egli mostrò le inequivocabili conseguenze dell’anonima e parossistica distruzione militare. Per Capa la guerra era un atto illegittimo in mano a poteri dittatoriali: egli la disprezzava e sperava, attraverso le sue immagini, di mobilitare altre persone, quante più persone possibili in ogni angolo del pianeta.[41] Capa offrì la sua visione pacifista e umanistica non solo attraverso celebri fotografie di soldati e combattenti, alcune di queste già menzionate in precedenza, ma anche e soprattutto, forse, attraverso sequenze tecnicamente innovative di immagini e narrazioni fotografiche che fungevano da complemento ideale alle popolari riviste degli anni Trenta e Quaranta:[42] si pensi, ad esempio, ai cinque, famosissimi reportage di guerra già citati e da questi realizzati tra la Spagna, la Cina e le spiagge della Normandia invasa dalle armate statunitensi, inglesi e franco-canadesi, capaci di imprimere una nuova ottica al contributo offerto dal fotogiornalismo.[43] Lo stile fotografico di Capa, a volte sgranato e come leggermente fuori fuoco, appunto, per le ragioni implicite e dalla profonda ispirazione emotiva ed intellettuale di cui sopra, può talora dare l’impressione che l’immagine sia frutto di una fortunata impulsività,[44] come quella prodotta da uno scatto di un telefonino tenuto a portata di mano da chicchessia ed utile ad immortalare l’evento improvviso e dell’ultim’ora che avviene in strada davanti ai nostri occhi, tornando a quanto asserito e tratteggiato nell’introduzione di questo lavoro. Impulsività che c’era e che, insieme col suo istinto primordiale e la raffinata capacità tecnica appresa con la pratica, costituisce la cifra immensa della sua imparagonabile bravura, ma c’era di più: come ci rivela gradualmente l’analisi del suo metodo di lavoro, quasi si procedesse allo sviluppo in analogico di una serie di negativi per arrivare all’immaginare finale, buona da stampare in chiaro una volta usciti dalla camera oscura, dai provini a contatto alle immagini stampate, per dirla altrimenti, risulta invero evidente una grande capacità di scovare le notizie di cronaca per poi distillarne gli aspetti principali in poche esplicite, ma efficaci immagini,[45] in grado di comporre e di ricomporre il senso smisurato e probabilmente non misurabile di un intenso ed inguaribile dramma umano. In un’epoca in cui le notizie erano trasmessa in una maniera che pretendeva di essere oggettiva perché ufficiale, Capa fece del reportage di parte, volutamente, caparbiamente e, forse, spudoratamente, un’arte.[46] Egli neppure fingeva mai di essere un testimone imparziale degli avvenimenti che voleva raccontare ed immortalare con le sue pellicole; aveva un punto di vista, quello sì assolutamente vero, genuino, unico e non filtrato; ed era quel punto di vista irrimediabilmente irriducibile o che potesse essere traslato ad una impostazione di generica appartenenza alla totalità, era la sua singolarità, piuttosto che un cieco inseguimento della notizia più attuale come da ipertrofia da agenzia di breaking news, a determinare la scelta dei suoi soggetti.[47] Convinto antifascista, si schierò con la causa repubblicana in Spagna e pubblicò il suo lavoro su un settimanale comunista edito a Parigi: il senso della verità, l’autenticità e l’integrità del suo lavoro hanno a che fare non tanto con la fedele registrazione degli avvenimenti in corso davanti al suo obiettivo, quanto con la appassionata, impegnata, avvincente narrazione della sua propria fotografia impegnata e di come e quanto questa, egli pensava, avrebbe influenzato il suo pubblico. Capa credeva fermamente che l’ampia diffusione della fotografia potesse, in qualche modo, far luce sulle ingiustizie e ispirare una trasformazione politica.[48] Traslando il significato dei suoi convincimenti e riportandoli alla nostra società contemporanea, al caso della morte di George Floyd con cui si è aperto questo racconto, si potrebbe pensare alla fotografia non solo fruita da una vasta moltitudine di persone ma nell’accezione di pratica comune e condivisa da centinaia di migliaia nel mondo grazie allo sviluppo della tecnologia digitale: e a quanto avvenuto per le manifestazioni iniziate e concluse al grido di “Black Lives Matter” (Le vite dei neri contano), per ciò che concerne il cambiamento se non possibile di certo auspicabile che egli sperava per l’umanità. Del resto, il cambiamento sociale rappresenta il fine ultimo della fotografia impegnata di Capa[49] e, allo stesso tempo, la missione del progetto dell’International Center of Photography (ICP), fondato nel 1974 da suo fratello minore Cornell: un incrocio fra un museo e una scuola, creato per conservare l’imponente e pregiatissimo archivio fotografico di Robert Capa ma anche per tramandare alle giovani generazioni ed alle nuove leve di fotoreporter la sua intima e profonda ispirazione artistica, il suo sguardo empatico e compassionevole delle vicende e dei problemi umani oggettivati attraverso l’insegnamento della fotografia, della sua fotografia.[50] Per raggiungere questi obiettivi, lodevoli ed impegnativi, il Centro Internazionale di Fotografia ha promosso nei decenni scorsi l’allestimento di più di trecento mostre fotografiche, alcune delle quali sono state realizzate come delle retrospettive delle opere di Capa.[51] Dal 1955 inoltre, appena un anno dopo la sua tragica e filmica scomparsa, viene assegnato dall’Overseas Press Club of America (OPC) il Premio Robert Capa Gold Medal, per “il miglior reportage fotografico all’estero, per realizzare il quale siano stati necessari eccezionali doti di coraggio e intraprendenza”, così recita la dicitura dell’ambito riconoscimento, vinto per la prima volta dal fotografo Howard Sochurek.[52] Si tratta del Word Press Photo Award, manifestazione omonima di una fondazione con sede a New York che raccoglie l’intera sua opera, grazie agli sforzi di Cornell, e che nel settore del fotogiornalismo è considerata al pari ed ha lo stesso valore in termini di prestigio di quello che rappresentano gli Oscar per la cinematografia mondiale. Eppure, scuola, museo e premio a parte, ciò che racconta meglio lo stile e la personalità di Capa restano le sue foto ed i suoi libri,[53] inscindibilmente connessi e correlati alle prime peraltro, che passeremo brevemente in rassegna di qui al termine di questo lavoro accademico. Cominciando da “Questa è la guerra! Robert Capa al lavoro”, che, appunto, non è altro che un testo del a noi già noto Richard Whelan, con introduzione di Christopher Phillips, ricavato da una mostra dedicata al fotografo ungherese con riproduzioni moderne in grande formato.[54] Un libro che raccoglie e presenta essenzialmente fotografie d’epoca, accompagnate in molti casi dalle stampe tratte dalle riviste su cui furono pubblicate per la prima volta.[55] La mostra pose e mette in relazione, al pari del saggio fotografico, il rapporto tra le stampe e le riviste, offrendo al lettore-visitatore nuove informazioni sotto forma di immagini inedite, rare foto censurate, una ricerca aggiornata sulle date e i luoghi in cui gli scatti furono realizzati, oltre ad un approfondito studio dei principali saggi fotografici di Robert Capa da lui stesso prodotti mentre era in vita. Un testo cui lavorò Whelan in qualità di sovrintendente al Robert Capa and Cornell Capa Archive che contiene, ancora, un’intensa revisione di alcune sezioni della biografia dedicata al fotografo ungherese dallo stesso Whelan e fornisce nuove, importanti interpretazioni della sua opera, edito in collaborazione con Willis E. Hartshorn, Direttore di Ehrenkranz.[56] Risultato della “paziente opera di ricerca del compianto Whelan”, scrive Phillips nella sua introduzione, è il frutto materiale ed intellettuale del lavoro del biografo ed amico, profondo conoscitore della vita e dell’opera di Capa. Un compendio nato dall’idea e dalla volontà perseguita da Whelan di offrire una nuova prospettiva al prodotto professionale di Capa come fotoreporter, esaminando scrupolosamente, come mai era stato fatto prima, il contesto di alcune delle fotografie più conosciute di Capa realizzate negli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso.[57] Uno studio minuzioso che, riteneva e desiderava Whelan, “avrebbe chiarito meglio le dinamiche e le scelte che hanno fatto di Capa uno dei più significativi interpreti del fotogiornalismo”,[58] professione ai suoi tempi ancora agli albori e di cui egli seppe esprimere e codificare i prodromi fondamentali ed imprescindibili. Quelle “conquiste individuali di Capa – scrive ancora Phillips – che possono quindi essere viste come parte di un quadro più ampio: quello della rivoluzione del giornalismo visivo che diede una nuova veste agli organi di informazione nel ventesimo secolo”[59] e che, ci piace sottolineare, fu praticata da Capa tutta la vita, sebbene questi, benché fosse uno dei fotografi più celebrati del suo tempo, non abbia “mai visto le sue immagini incorniciate ed esposte in una galleria o in un museo”.[60] “Robert Capa, la verità è lo scatto migliore” di Florent Silloray pubblicato da Edizioni White Star e “Robert Capa, Normandia 6 giugno 1944” edito dalla Magnum Photos e Roberto Koch Editore sono due testi di fotografie e a fumetti molto interessanti e ben fatti, alla cui produzione hanno contribuito, oltre agli autori, diverse figure di professionisti in qualità di sceneggiatori, disegnatori e fumettisti. Nel primo, “Robert Capa, la verità è lo scatto migliore”, l’autore passa in rassegna l’intera vicenda biografica e professionale del fotografo ungherese, i suoi viaggi, i suoi amori, le sue passioni, prendendo spunto proprio da uno di quei reportage originali ed autobiografici scritti dallo stesso Capa, in cui, scrive Silloray, il fotoreporter “fa il punto di una vita passata a fotografare i campi di battaglia del mondo intero, lontano dall’immagine di testa calda che gli è stata attribuita e che l’ha reso una leggenda del fotogiornalismo”[61] e in cui di suo pugno Capa “si racconta senza filtri e svela la ferita originale che ha indirizzato il corso di tutta la sua vita”.[62] Nel secondo, “Robert Capa, Normandia 6 giugno 1944”, vengono sceneggiati come fumetti da Jean David Morvan e Séverin Tréfouël, con dossier archivistico a cura di Bernard Lebrun e disegni della matita di Dominique Bertail, le stesse fotografie di Capa, raccolte nella seconda sezione del testo, scattate durante lo sbarco degli eserciti alleati che si opponevano al nazi-fascismo sulle coste settentrionali francesi:[63] sbarco che divenne epico, anche grazie agli scatti temerari ed indimenticabili di Capa, utilizzati successivamente nello screen-play di decine di pellicole cinematografiche che nutrivano desiderio ed ambizione di autenticità da reportage. “Robert Capa” di Gnugnoli, pubblicato da Giunti nella collana “Artedossier”, è una sorta di album fotografico sul percorso esistenziale e lavorativo del reporter ungherese, con l’aggiunta di testi che ne spiegano i passaggi salienti e più significativi.[64] Aperto in epigrafe da una citazione di Henri Cartier-Bresson, che insieme con lui ed altri aveva fondato la Magnum Photos, e che recita testualmente “Per me Capa è stato un grande giocatore. Ha combattuto per sé e per gli altri. Il destino aveva deciso che fosse abbattuto all’apice della sua gloria.”, il testo procede per capitoli ben ordinati ed incardinati cronologicamente, prendendo le mosse da quando Capa, da esule sconosciuto, divenne un fotografo di successo a “Il miliziano: l’esordio di un leggendario fotografo di guerra”, continuando con “Professione pericolo: dallo sbarco in Normandia alla liberazione di Parigi” e “Pieno di vita all’appuntamento con la morte”, testimonianza degli eventi che portarono alla sua scomparsa nel 1954.[65] Ad ogni modo, forse e probabilmente perché scritto da un suo compagno di viaggio, nonché premio Nobel per la letteratura, sebbene il testo rechi numerose citazioni di Capa e un paragrafo scritto dal fotoreporter ungherese,[66] il documento più veritiero e calzante dell’animo e dell’idea che del lavoro aveva il reporter ungherese resta a nostro avviso ed in conclusione “Diario Russo”, di John Steinbeck, già citato in altra parte di questo lavoro e pubblicato da Bompiani in prima edizione nel 2018: un resoconto onesto e privo di ideologia sulla vita quotidiana di un popolo che non poteva essere più lontano dall’American way of life, che pure Capa amava immensamente e di cui era profondamente intriso l’odore acetato delle sue pellicole e quello al malto e all’aroma delle gocce di whisky cadute sui suoi vestiti. Le pagine del diario e le fotografie che raccontano la vita a Mosca, Kiev, Stalingrado e nella Georgia[67] sono il distillato di un viaggio straordinario e un documento storico unico di un’epoca, salutato dal New York Times come “un libro magnifico” alla sua uscita.[68] Un reportage culturale, più che di guerra, questo, con tutta la sua bellezza, sulla gente comune di uno dei Paesi meno conosciuti ed esplorati dai reporter a quel tempo, da qualsiasi parte del mondo provenissero, tanto meglio se da occidente rispetto alla “cortina di ferro”. Un libro che finisce per caratterizzarsi come e lasciare il lettore con una notevole lezione di umanità ed empatia che ricorda a tutti, ancora oggi, l’importanza di conoscere davvero e concretamente luoghi e persone per superare pregiudizi stantii ed estraniante ignoranza disumanizzante, grazie al quale Steinbeck e Capa riuscirono nel loro fermo intento, preambolo irrinunciabile alla base del viaggio stesso che essi intrapresero tra mille difficoltà, di “dare un volto al nemico”, troppo spesso ed artatamente disumanizzato a scopi propagandistici dalla retorica politica ufficiale.[69] Se gli altri reportage realizzati da Capa e di cui abbiamo dato conto nel testo, erano tutti, fondamentalmente, reportage di un conflitto, “Diario Russo” è altresì la testimonianza vivida e sincera, immediata, di ciò che vive una nazione attraversata e distrutta da una guerra, come nel caso dell’Unione Sovietica post bellica che Capa e Steinbeck visitarono nel 1947. Non avevano altre ragioni, altri interessi e altri desideri, entrambi, di raccontare la verità così come essi la avrebbero vista, o come sarebbe loro apparsa, per allontanarsi il più possibile dai cliché tipici e tanto in voga durante la guerra fredda tra URSS e USA, Oriente e Occidente. Spingendosi fino agli affreschi più indigesti e terribili della cruda realtà, tratteggiati a penna in schizzi di appunti o impressi su pellicole dall’apparecchio fotografico come quello in cui riportano uno delle decine e decine di racconti ascoltati da operai, contadini, semplici cittadini, questo ambientato nella Stalingrado durante la ricostruzione post-bellica, sui risvolti macabri e impensabili e sulle conseguenze che l’invasione nazista dell’Operazione Barbarossa si era lasciata alle spalle nelle steppe infinite dell’antica Russia: “In mezzo alla musica lieve, alle luci, di fronte al pacifico scorrere del fiume, i nostri amici ricominciarono a parlare della guerra, come se fosse un pensiero assillante di cui non si potevano liberare. Parlarono di cose terribili che non riuscivano a dimenticare. Di come un uomo si fosse scaldato le mani nel sangue di un suo amico appena ucciso per poter premere il grilletto del suo fucile”.[70] La prospettiva e la normale architettura narrativa, talvolta, nel testo viene ribaltata, nel senso che non sono le immagini a fare da corredo didascalico immediatamente e visivamente fungibile delle parole, ma viceversa, con la sintassi a compendio esplicativo degli scatti di Capa:[71] artificio, quest’ultimo, sperimentato consapevolmente, minuziosamente perseguito e fortemente voluto dai due intellettuali americani protagonisti del viaggio-avventura autobiograficamente narrato, per la forza stessa delle fotografie di Capa e perché essi avevano in animo di raccontare e riportare quanto visto e sentito con immediatezza e naturalezza, senza fuorvianti sovrastrutture né lenti ideologiche e nella maniera più fondata e veritiera possibile, senza altra ambizione personale o professionale che questa. Un libro dall’andamento positivo, lineare e cronologicamente ordinato, che si legge con facilità se non con avidità, considerata la scelta obbligata dell’itinerario e, dunque, quasi esclusivamente, degli argomenti trattati,[72] imposti dai luoghi di volta in volta visitati dai due, costantemente accompagnati da un ufficiale del governo sovietico.[73] Le premesse del libro, però, sono state esplicitate dai due reciprocamente l’uno all’altro in piena libertà intellettuale e di coscienza, senza nulla di preconfezionato, tanto che il viaggio stesso, e i paletti del discorso da fare agli americani una volta rientrati in patria, erano stati stabiliti tra un superalcolico e l’altro al bancone del Bedford Hotel di New York, dove Capa e Steinbeck erano soliti incontrarsi, bere, chiacchierare ed ascoltare i consigli del loro fidato barista, chiamato affettuosamente Willy[74] e realmente esistito. Al lettore appare chiaro sin dalle pagine iniziali che il viaggio-racconto si svolge tra due parentesi: la sanguinosa guerra appena conclusa e l’atroce e preoccupante prospettiva di un conflitto atomico da evitare a ogni costo,[75] almeno nelle intenzioni dei protagonisti e di tutti i personaggi intervistati e fotografati nell’atto di brindare alla pace nel mondo e tra i popoli. “Nel mezzo – scrive nella sua introduzione al testo Luigi Sanpietro – una serie di incontri e di esperienze con un’umanità per nulla incline al carpe diem realistico e rassegnato e che, nel perdurare delle ristrettezze, manifesta una idealistica e vigorosa voglia di vivere”, con “la politica e i rapporti di forza tra i potenti che sfumano sullo sfondo”, quasi a fare da scenografia per gli scatti in primo piano di Capa, e lo sguardo che volge, “soprattutto nelle città devastate dai tedeschi”, sulle “rovine” che presto spariranno per lasciare spazio “a un futuro di prosperità e di pace”.[76] “Diario Russo” fu un reportage che per un certo periodo non dispiacque neppure alle autorità sovietiche, le quali, però, già qualche anno dopo, con l’ulteriore abbassarsi della temperatura tra le due superpotenze, finirono col proibire la circolazione dell’opera nell’intero Paese[77] che fu degli zar prima e dei commissari del popolo poi, ora preda di despoti autocratici e feroci, ancor più con i giornalisti,[78] alla stregua del Presidente Vladimir Putin. Ciò nondimeno Capa ebbe i suoi bei grattacapi per scattare le sue fotografie, in alcuni posti rigidamente e assolutamente proibite per il timore intrinseco che le autorità sovietiche nutrivano nei confronti della possibile e rivoluzionaria veridicità fornita e suggerita dal mezzo fotografico, come all’interno del Cremlino o nella fabbrica di trattori di Stalingrado,[79] considerata luogo di attività strategiche e coperto dal segreto militare, con suo enorme rammarico. Non gli fu proibito però, riporta Steinbeck, di fotografare persone, magazzini, strade né le sue pellicole, eccezion fatta per qualche negativo, furono alfine sottoposte a censura prima del volo di ritorno che li condusse a Praga,[80] dopo circa due mesi di visita, coincisi con la data in cui a Mosca venivano celebrati con grandiosi festeggiamenti tipici da regime gli ottocento anni dalla fondazione della capitale. Dal testo emerge tutta intera la personalità di Capa: un uomo preparato, che amava rubare libri ai corrispondenti esteri delle testate statunitensi residenti in Russia, o “prenderli in prestito” come diceva lui e racconta ancora Steinbeck. Un uomo socievole, acuto, dal carattere gioviale, che amava gli uomini in generale e le “belle donne con caviglia stretta e rossetto” in particolare, che adorava lo swing americano e ballare, che non disdegnava la buona tavola e cui piaceva tanto fumare una gustosa sigaretta aromatica; dalla personalità talora introversa, come quando al mattino restava per ore chiuso nel bagno in vasca a leggere[81] scatenando le ire e la riprovazione del suo compagno di viaggio, e un’attenzione meticolosa e precisissima, una passione instancabile per il suo lavoro di fotografo, che poteva indurlo a comportamenti propri di una dimensione maniacale nella cura delle sue attrezzature, di cui era gelosissimo, e delle sue diapositive, che in fondo non lo lasciavano mai completamente soddisfatto sulla bontà del compito portato a termine, convinto com’era, sempre, che avesse scattato le foto più brutte e più inutili del mondo.[82] “Non sono per niente contento. Dieci anni fa, quando cominciai a guadagnarmi la vita vendendo fotografie di gente bombardata dagli aeroplani con la svastica, vidi alcuni piccoli aeroplani con la stella rossa abbattere quelli con la svastica” , scrive Capa nel capitolo intitolato “Un legittimo lamento”, inserito nel romanzo-reportage di Steinbeck e vergato di sua penna. E continua: “Decisi che desideravo vedere e conoscere il luogo da dove provenivano questi aeroplani e questi piloti. Desideravo visitare e fotografare l’Unione Sovietica. Volli tentare l’esperimento. L’estate scorsa i russi finirono col diventare particolarmente invisi da questa parte e c’era il rischio che si cominciasse a sparare. Dischi volanti e bombe sono davvero poco fotogenici, così decisi di fare l’ultima richiesta prima che fosse troppo tardi…Ora è notte tarda e io sono seduto nel centro di una stanza d’albergo estremamente cupa, circondato da centonovanta milioni di russi, quattro macchine fotografiche, poche dozzine di pellicole impressionate e molte di più non ancora impressionate, uno Steinbeck che dorme, e io non sono per niente contento. I centonovanta milioni di russi sono contro di me. Non ci sono scontri all’angolo delle strade, né casi di libero amore che facciano scandalo, non hanno un aspetto che salti all’occhio, ma sono gente onesta, dabbene e dedita al lavoro; e per un fotografo sono un cibo che non sa di niente: Del resto pare che amino quel loro modo di vivere e odino farsi fotografare. Le mie quattro macchine fotografiche, abituate a guerre e a rivoluzioni, sono deluse e tutte le volte che faccio uno scatto c’è qualcosa che va storto”.[83] “Avremmo lavorato insieme – scrive Steinbeck. Avremmo evitato la politica e i grandi problemi. Ci saremmo tenuti alla larga dal Cremlino, dai militari e dai piani militari. Quello che volevamo, se ci fosse stato possibile, era conoscere il popolo russo. Concepimmo il nostro piano in questo modo: se fosse stato possibile, sarebbe stata una bella cosa e avremmo avuto il materiale per un buon libro; se non ci fosse stato possibile, avremmo avuto lo stesso del magnifico materiale per un buon libro, sul non averlo potuto fare”.[84] E, ancora: “Insieme progettammo un monte di altre cose; non dovevamo assolutamente andare in Russia con idee preconcette o riserve mentali e bisognava evitare di essere ostili o favorevoli. Quello che dovevamo fare era un onesto servizio cronistico: scrivere quello che vedevamo e udivamo senza commenti di carattere redazionale, senza trarre conclusioni su cose che non conoscevamo abbastanza e senza arrabbiarci per le lungaggini della burocrazia. Sapevamo che ci sarebbero state molte cose che non avremmo capito, molte cose che ci avrebbero messo a disagio. Ciò vale sempre, allorché si tratti di andare in un paese straniero. Ma noi decidemmo che, se fosse stato necessario fare delle critiche, queste avrebbero avuto luogo dopo, non prima, di avere visto”.[85] E, terminando, chiosa: “questo è tutto. Ed è la cosa per cui abbiamo fatto questo viaggio. Per scoprire, come sospettavamo, che i russi sono un popolo come gli altri, e che sono molto simpatici. Quelli con cui abbiamo parlato odiavano la guerra e amavano le stesse cose che amano tutti i popoli: vivere il meglio possibile con tutte le comodità, in sicurezza e in pace. Sappiamo che questo diario non soddisferà né i chierici della sinistra né il sottoproletariato di destra. I primi diranno che è antirusso, gli altri che è filorusso…Non abbiamo conclusioni da trarre, tranne che il popolo russo è come tutti i popoli del mondo. Di certo c’è gente cattiva tra loro, ma i buoni sono la stragrande maggioranza”.[86] E, più che le parole, a testimoniare questa verità, come nel caso di Floyd con il lamento supplichevole e disperato, “I can’t breathe”, furono le immagini. Sono state le fotografie di Robert Capa.
Bibliografia e fonti digitali
- Leggermente fuori fuoco, Robert Capa, Contrasto di Roberto Koch Editore srl, Roma, 2019
- Robert Capa: la verità è lo scatto migliore, Florent Silloray, Edizioni White Star, Milano, 2018
- Questa è la guerra! Robert Capa al lavoro, Richard Whelan, Contrasto di Roberto Koch Editore srl, Roma, 2009
- Robert Capa, Normandia 6 Giugno 1944, Jean David Morvan e Séverin Tréfouël, Contrasto di Roberto Koch Editore srl, Roma, 2017
- Robert Capa, Alberta Gnugnoli, Giunti, Firenze, 2010
- Diario russo, John Steinbeck, Bompiani, Firenze, 2018
- La società dello spettacolo, Guy Debord, Massari Editore, Bolsena (VT), 2002
- La macchina fotografica che non mente mai, Phillip Knightley, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1975
- Storia della Fotografia: il fotogiornalismo, Ilaria Vangi, IgersItalia, Prato, 2014
- Quando la fotografia diventa informazione: storia ed evoluzione del fotogiornalismo in Italia, Antonella Tancredi, Fotografia&Informazione, Roma, 2001
- Operazione Husky, dopo 75 anni commemorato lo sbarco degli alleati in Sicilia, Eliseo Davì, ErsuCultura, Catania, 2018
- Il Fotogiornalismo, la storia, Andrea Frazzetta, ptoreporting.blogspot.com, 2011
- Fotogiornalismo, Franco Lever, www.lacomunicazione.it, 2020
- Robert Capa, GrandiFotografi.com
- Wikipedia.org per le voci Ropert Capa e Magnum Photos
Note
[1] Ivi.
[2] Robert Capa, Wikipedia.org.
[3] Ivi.
[4] Ivi e Richard Whelan, Questa è la guerra, Robert Capa al lavoro, Contrasto di Roberto Koch Editore srl, Roma, 2009.
[5] Richard Whelan, Questa è la guerra, Robert Capa al lavoro, Contrasto di Roberto Koch Editore srl, Roma, 2009.
[6] Ivi.
[7] Ivi.
[8] Alberta Gnugnoli, Robert Capa, Giunti, Firenze, 2010.
[9] Ivi e Richard Whelan, Questa è la guerra, Robert Capa al lavoro, Contrasto di Roberto Koch Editore srl, Roma, 2009.
[10] Robert Capa, Leggermente fuori fuoco, Contrasto di Roberto Koch Editore srl, Roma, 2019.
[11] Robert Capa, GrandiFotografi.com.
[12] Magnum Photos, Wikipedia.
[13] Ivi.
[14] Robert Capa, GrandiFotografi.com.
[15] Magnum Photos, Wikipedia.
[16] Robert Capa, GrandiFotografi.com.
[17] Magnum Photos, Wikipedia.
[18] Robert Capa, GrandiFotografi.com e Robert Capa, Leggermente fuori fuoco, Contrasto di Roberto Koch Editore srl, Roma, 2019.
[19] John Steinbeck, Diario Russo, Bompiani, Firenze, 2018, pag. 262 e ss., 276 e 281 e ss..
[20] John Steinbeck, Diario Russo, Bompiani, Firenze, 2018, introduzione e cap. 1.
[21] Robert Capa, GrandiFotografi.com e Robert Capa, Leggermente fuori fuoco, Contrasto di Roberto Koch Editore srl, Roma, 2019.
[22] Jean David Morvan e Séverin Tréfouël, Robert Capa, Normandia & giugno 1944, Contrasto di Roberto Koch Editore srl, Roma, 2017.
[23] Robert Capa, GrandiFotografi.com
[24] Robert Capa, Leggermente fuori fuoco, Contrasto di Roberto Koch Editore srl, Roma, 2019.
[25] Ivi.
[26] Ivi.
[27] Ivi.
[28] Ivi.
[29] Ivi e Jean David Morvan e Séverin Tréfouël, Robert Capa, Normandia & giugno 1944, Contrasto di Roberto Koch Editore srl, Roma, 2017.
[30] Robert Capa, Leggermente fuori fuoco, Contrasto di Roberto Koch Editore srl, Roma, 2019.
[31] Robert Capa, Leggermente fuori fuoco, Contrasto di Roberto Koch Editore srl, Roma, 2019, introduzione.
[32] Ivi.
[33] Ivi.
[34] Ivi e Alberta Gnugnoli, Robert Capa, Giunti, Firenze, 2010.
[35] Robert Capa, Leggermente fuori fuoco, Contrasto di Roberto Koch Editore srl, Roma, 2019.
[36] Ivi.
[37] Alberta Gnugnoli, Robert Capa, Giunti, Firenze, 2010 e Jean David Morvan e Séverin Tréfouël, Robert Capa, Normandia & giugno 1944, Contrasto di Roberto Koch, Roma, 2017.
[38] Richard Whelan, Questa è la guerra, Robert Capa al lavoro, Contrasto di Roberto Koch Editore srl, Roma, 2009.
[39] Robert Capa, Leggermente fuori fuoco, Contrasto di Roberto Koch Editore srl, Roma, 2019.
[40] Richard Whelan, Questa è la guerra, Robert Capa al lavoro, Contrasto di Roberto Koch Editore srl, Roma, 2009.
[41] Ivi.
[42] Ivi
[43] Ivi e Jean David Morvan e Séverin Tréfouël, Robert Capa, Normandia & giugno 1944, Contrasto di Roberto Koch Editore srl, Roma, 2017.
[44] Richard Whelan, Questa è la guerra, Robert Capa al lavoro, Contrasto di Roberto Koch Editore srl, Roma, 2009.
[45] Ivi.
[46] Ivi.
[47] Ivi.
[48] Ivi.
[49] Ivi.
[50] Ivi e Robert Capa, Leggermente fuori fuoco, Contrasto di Roberto Koch Editore srl, Roma, 2019.
[51] Richard Whelan, Questa è la guerra, Robert Capa al lavoro, Contrasto di Roberto Koch Editore srl, Roma, 2009.
[52] Robert Capa, Wikipedia.org.
[53] Alberta Gnugnoli, Robert Capa, Giunti, Firenze, 2010 e Jean David Morvan e Séverin Tréfouël, Robert Capa, Normandia & giugno 1944, Contrasto di Roberto Koch, Roma, 2017.
[54] Richard Whelan, Questa è la guerra, Robert Capa al lavoro, Contrasto di Roberto Koch Editore srl, Roma, 2009.
[55] Ivi, pag. 12 e ss..
[56] Richard Whelan, Questa è la guerra, Robert Capa al lavoro, Contrasto di Roberto Koch Editore srl, Roma, 2009.
[57] Ivi, introduzione.
[58] Ivi.
[59] Ivi.
[60] Ivi.
[61] Florent Silloray, Robert Capa: la verità è lo scatto migliore, Edizioni White Star, Milano, 2018.
[62] Ivi.
[63] Jean David Morvan e Séverin Tréfouël, Robert Capa, Normandia & giugno 1944, Contrasto di Roberto Koch, Roma, 2017.
[64] Alberta Gnugnoli, Robert Capa, Giunti, Firenze, 2010.
[65] Ivi.
[66] John Steinbeck, Diario Russo, Bompiani, Firenze, 2018, pag.209.
[67] John Steinbeck, Diario Russo, Bompiani, Firenze, 2018, pag. 39, 101, 179, 244.
[68] John Steinbeck, Diario Russo, Bompiani, Firenze, 2018, introduzione.
[69] Ivi.
[70] John Steinbeck, Diario Russo, Bompiani, Firenze, 2018, pag. 5 e 167 e ss..
[71] John Steinbeck, Diario Russo, Bompiani, Firenze, 2018, pag. 19 e ss..
[72] John Steinbeck, Diario Russo, Bompiani, Firenze, 2018, introduzione.
[73] John Steinbeck, Diario Russo, Bompiani, Firenze, 2018, pag. 27 e ss..
[74] John Steinbeck, Diario Russo, Bompiani, Firenze, 2018, introduzione.
[75] Ivi.
[76] Ivi.
[77] Ivi.
[78] Risulta in proposito tristemente emblematica la storia della giornalista russa Anna Politkovskaja, ritrovata morta il 7 ottobre 2006 dopo essere stata rapita da una squadraccia.
[79] John Steinbeck, Diario Russo, Bompiani, Firenze, 2018, pag. 167 e ss. e 275 e ss..
[80] John Steinbeck, Diario Russo, Bompiani, Firenze, 2018 pag. 275 e ss..
[81] John Steinbeck, Diario Russo, Bompiani, Firenze, 2018 e Jean David Morvan e Séverin Tréfouël, Robert Capa, Normandia & giugno 1944, Contrasto di Roberto Koch, Roma, 2017.
[82] John Steinbeck, Diario Russo, Bompiani, Firenze, 2018, pag. 209 e ss..
[83] Ivi.
[84] John Steinbeck, Diario Russo, Bompiani, Firenze, 2018, pag. 21.
[85] Ivi.
[86] John Steinbeck, Diario Russo, Bompiani, Firenze, 2018, pag. 306 e 307.
[1] Guy Debord, La società dello spettacolo, Massari Editore, Bolsena (VT), 2002, prefazione alla quarta edizione italiana.
[2] Ivi.
[3] John Steinbeck, Diario Russo, Bompiani, Firenze, 2018, pag. 185.
[4] Andrea Frazzetta, Il Fotogiornalismo, la storia, photoreporting.blogspot.com, 2011.
[5] Ivi.
[6] Ivi.
[7] Ivi.
[8] Phillip Knightley, La macchina fotografica che non mente mai, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1975.
[9] Franco Lever, Fotogiornalismo, www.lacomunicazione.it, 2020.
[10] Ivi.
[11] Andrea Frazzetta, Il Fotogiornalismo, la storia, photoreporting.blogspot.com, 2011.
[12] Franco Lever, Fotogiornalismo, www.lacomunicazione.it, 2020.
[13] Ivi.
[14] Ivi.
[15] Ivi.
[16] Robert Capa, GrandiFotografi.com.
[17] Franco Lever, Fotogiornalismo, www.lacomunicazione.it, 2020.
[18] Ivi.
[19] Ivi.
[20] Magnum Photos, Wikipedia.
[21] Ilaria Vangi, Storia della fotografia: il fotogiornalismo, IgersItalia, Prato, 2014.
[22] Antonella Tancredi, Quando la fotografia diventa informazione: storia ed evoluzione del fotogiornalismo in Italia, Fotografia&Informazione, Roma, 2001.
[23] Ilaria Vangi, Storia della fotografia: il fotogiornalismo, IgersItalia, Prato, 2014.
[24] Ivi.
[25] Ilaria Vangi, Storia della fotografia: il fotogiornalismo, IgersItalia, Prato, 2014.
[26] Ilaria Vangi, Storia della fotografia: il fotogiornalismo, IgersItalia, Prato, 2014.
[27] Andrea Frazzetta, Il Fotogiornalismo, la storia, photoreporting.blogspot.com, 2011.
[28] Ilaria Vangi, Storia della fotografia: il fotogiornalismo, IgersItalia, Prato, 2014.
[29] Ivi.
[30] Eliseo Davì, Operazione Husky, dopo 75 anni commemorato lo sbarco degli alleati in Sicilia, ErsuCultura, Catania, 2018.
Si ringrazia Lorenzo Di Nola per il contributo indispensabil fornito alla realizzazione di questo articolo